Libri
Comunità. Natura, cultura… terapia
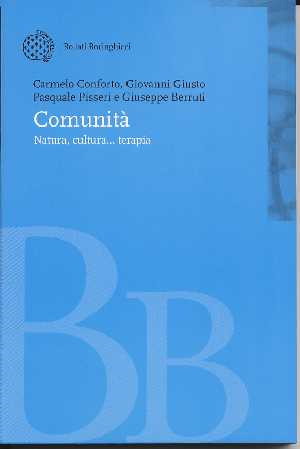
Carmelo Conforto, Giovanni Giusto, Pasquale Pisseri
1999 Bollati Boringhieri
COD: R001
€18
Il percorso teorico della psicoanalisi si è progressivamente distanziato da un modello dello sviluppo psicologico centrato quasi esclusivamente sul progressivo strutturarsi di uno psichico in gran parte autocreato dal soggetto, per giungere a un secondo modello, che attribuisce all’esperienza relazionale (nelle sue varie configurazioni) la dimensione fondamentale entro cui si avvia e progredisce lo strutturarsi dello psichico (o si riconducono le ragioni delle sue deformazioni e lacerazioni).
Questo secondo modello (al di là delle varie scuole che lo interpretano) afferma, in sintesi, che la crescita psichica (il suo sviluppo) nell’uomo ha assoluto bisogno, per verificarsi, di un particolare rapporto con altri umani, la madre, il padre, la famiglia nel suo complesso.
Ciò che avviene tra il piccolo dell’uomo e l’ambiente di accudimento (ci riferiamo agli scambi senso-percettivi, affettivi e simbolici) è la base da cui si avvia il percorso naturale verso l’evoluzione e la maturazione del Sé, così come verso la sua deformazione, frammentazione, amputazione In un volumetto prezioso Meitzer e Harris Williams, affrontando il tema del Ruolo educativo della famiglia (1983), si soffermano sulle caratteristiche (viste da un vertice strettamente psicoanalitico) della Comunità e sulla loro influenza sulla Famiglia.
Ciò che si evidenzia in quelle pagine è la continua attenzione alla differenza tra un’organizzazione comunitaria che possa sentirsi responsabile e un’altra che opera come se lo fosse. L’ipotesi del “come se” è centrata sul modello della comunità che “agisce”, inconsciamente, un mito, che, sostenuto da strutture psichiche assolutamente arcaiche (pari agli “assunti di base” del modello bioniano), ha difficoltà a permettere lo svolgersi delle funzioni del “gruppo di lavoro” (Bion, 1961). In una sorta di percorso itinerante verso le organizzazioni più catastrofiche e folli, gli autori descrivono innanzitutto la comunità benevola, sostenuta dal mito inconscio di una coppia genitoriale al potere (proprietario e direttore, ad esempio) che simula una relazione felice e organizzata a favore dei “figli” mèmbri della comunità. Essa trasmetterà progetti e norme che, discendendo da sentimenti “come se” di benevolenza e saggezza, non saranno in grado di reggere a situazioni di tensione: saranno necessari allora dei modi di difesa, come l’esclusione di alcuni mèmbri “devianti”, fino a che altre strutture comunitarie (così come accade per gli “assunti di base”) presenti a livello latente non si impongano nella dirigenza della comunità.
Queste comunità hanno la caratteristica di reggersi su funzioni genitoriali (svolte da chi sovraintende) non più complementari: sono allora comunità condotte da un solo genitore, che si offre come partner alla comunità nel momento in cui l’altro genitore viene ritenuto non più in grado di adempiere ai suoi compiti idealizzati (coraggio, abnegazione, dedizione).
La possibilità che questo adattamento organizzativo funzioni (nel modo del “come se”) è relativamente ridotta, in quanto si aprono varchi sempre più ampi a rapporti improntati a sfiducia, e la crescente percezione di relazioni di sfruttamento e di sospettosità sfocerà infine nella comunità paranoide, in cui il vissuto di armonia che sorreggeva la comunità benevola è sovvertito dall’ingresso del male, della corruzione, e infine della rivoluzione, perché il bene trionfi sul male. Così il cerchio si chiude, con un avvertimento, da parte di Meitzer e IIarris Williams: così come dice Bion a proposito degli assunti di base, ognuna di queste tendenze, quando governa la comunità, contiene a livello latente anche le altre, pronte a manifestarsi. L’interesse di questo contributo sta poi nel tentativo di definire i ruoli e le funzioni dell’organizzazione che sta a valle della comunità, ovvero la famiglia, tentando di leggerli alla luce delle categorie precedenti.
Per quello che qui ci interessa riprendere dal lavoro di Meitzer e Harris Williams (per poi tentarne una lettura in situazioni e strutture dedite ufficialmente alla terapia e al recupero dei pazienti psichiatrici), riferiremo le funzioni emotive che secondo gli autori organizzano le relazioni familiari.
1) Generare amore;
2) suscitare odio;
3) infondere speranza;
4) seminare disperazione;
5) contenere la sofferenza depressiva;
6) trasmettere ansia persecutoria;
7) creare confusione;
8) pensare.
L’idea su cui si fondano queste funzioni emotive è interessante (anche se non facile), rivelandosi come un complesso tentativo di estendere e integrare le osservazioni di Bion sul funzionamento gruppale (appunto oscillante tra assunti di base e gruppo di lavoro) con le teorie kleiniane (e di Meitzer stesso) sulle diverse strutture (posizioni) della mente dell’individuo.
Il tentativo di descrivere (nella gruppalità e nel singolo) i fenomeni mentali e di muoversi alla ricerca delle ragioni (inconsce) del loro continuo comparire e scomparire, oscillando in una sorta di percorso interminabile (<->), ci è parso una traccia feconda da ripercorrere nel nostro tentativo di leggere da questo vertice (psicoanalitico) ciò che accade in comunità terapeutica. Meitzer e Harris Williams suggeriscono che le funzioni che permettono lo sviluppo psichico nei mèmbri di una famiglia o di una struttura che per finalità espressa si propone di svolgere compiti simili a quelli di una famiglia, sono necessariamente quelle che attivano la capacità di pensare e (noi aggiungeremo, utilizzando Bion, 1961) la capacità di apprendere dall’esperienza.
Le funzioni emotive allora possono essere lette come facilitanti o inibenti questo apprendimento. Il legame d’amore (da cui per Bion dipende la capacità di rèverie della madre nei confronti del figlio), la speranza e il contenimento della sofferenza depressiva (connessi all’introiezione dell’oggetto buono) sono in effetti legami e funzioni che consentono di tollerare le emozioni originate dal confronto con ciò che da presenza si fa assenza, promuovendo le attività del pensiero che muovono (+ K) verso la sua rappresentabi-lità. Scrive Bion (1965, p. 113): “Ogni parola rappresenta ciò che non è (una non-cosa che deve essere distinta dal niente).
” Pensiamo non sia inutile ricordare che questa modalità di funzionamento (conscio o inconscio che sia) di un insieme familiare, gruppale, comunitario è da Meitzer e PIarris Williams temporalizzata sia come modo (^.funzionamento momentaneo sia come linea di tendenza, per mostrarne la precarietà e la difficoltà a mantenersi nel tempo. Questa precisazione ci pare assolutamente fondamentale e d’al- tra parte prevedibile alla luce delle fonti (come abbiamo accennato) da cui trae alimento, vale a dire le teorie kleiniane e bioniane sul funzionamento psichico del singolo e del gruppo. Tenere conto di questa dimensione, ovvero dell’incostanza delle diverse organizzazioni mentali (individuali e di gruppo), ci pare una consapevolizzazione per taluni aspetti “depressiva”: tuttavia l’ignorarla o, meglio, le ragioni del suo diniego sono l’espressione di bisogni narcisistici, mitici appunto, e pertanto in contrapposizione con le strutture mentali capaci di apprendere dall’esperienza.
Tanto più che Bion nel suo lavoro sui gruppi afferma (1961, p. 145): “Secondo me uno degli aspetti più sorprendenti di un gruppo è il fatto che, nonostante l’influenza degli assunti di base, il gruppo razionale o di lavoro alla fine esce trionfatore.” Della complessa teoria bioniana utilizziamo l’ipotesi di una continua lotta nei gruppi (terapeutici e non) tra le forze arcaiche, sorrette da emozioni intensissime, che “legano” tutti i componenti del gruppo nella partecipazione ai progetti degli assunti di base, opponendosi al loro sollevarsi dai dettati del “principio di piacere-dispiace-re” per accedere al gruppo di lavoro, ovvero all’utilizzazione del principio di realtà e al pensare. Questa definizione fondamentale delle dimensioni della conflittualità gruppale viene riletta da Meitzer e Harris Williams, che descrivono i programmi gruppali (familiari) progettati (inconsciamente) per demolire la collaborazione creativa (trasmettere ansia persecutoria, creare bugie e confusione, suscitare odio), consentendoci di allargare il discorso alla ricerca di ulteriori ragioni del loro prodursi. Molte risposte si possono ritrovare nella corrente di pensiero kleiniana e bioniana alla quale abbiamo fatto fino ad ora riferimento.
Ci riferiamo ad esempio alla consulenza istituzionale di orientamento psicoanalitico di Menzies Lyth (1988) e alle sue ricerche sulla cultura di lavoro, ovvero sulle “credenze” che animano il gruppo e che si sviluppano nel progetto di lavoro, e sull’analisi dei ruoli, che risultano influenzati dalle esigenze proiettive del gruppo. L’autrice, sulla base della sua esperienza, osserva: “Troppe comunità terapeutiche sembrano mancare di una sufficiente consapevolezza dei ruoli e dei fattori strutturali e quindi il loro impatto terapeutico viene ridotto perché si dimostrano inadeguate” (p. 326). D’altronde ogni istituzione, che inevitabilmente chiede ai suoi mèmbri di identificarsi con le sue caratteristiche, pena l’espulsione, tende con facilità, come descritto da molti (Kaès, Bergler e altri, 1988), a costruire inconsciamente organizzazioni che contengono difese contro angosce assai intense, di ordine psicotico (Jaques, 1970).
Per perpetuarsi le istituzioni hanno necessità di escludere ciò che è incompatibile con il loro mantenimento inconsapevole: ovvero quel modo di usare la mente che è consono al pensare e al rispetto dei principio di realtà, strettamente connesso, come abbiamo visto, alla possibilità di contenere la sofferenza depressiva e di apprendere dall’esperienza. Correale, nel quinto capitolo di questo volume, accenna al necessario lento processo di familiarizzazione che l’ospite ha necessità di compiere, nel suo esplorare una quotidianità che è calda e ricca, per potersi proporre come ricostruttiva della coesione del Sé.
In queste pagine introduttive segnaliamo il nostro progetto: muoverci (mentalmente e nei fatti) nella direzione della famiglia calda e ricca che possa consentire agli ospiti tale familiarizzazione. Questo “tendere verso” è, nella realtà che abbiamo sperimentato, coincidente con le modalità di funzionamento momentaneo descritte da Meitzer e Harris Williams. L’abitudine, affaticante quanto indispensabile, a creare spazi di pensiero per gli operatori, si esprime attraverso momenti dedicati alla riflessione gruppale, alla supervisione: un modello di lavoro in questa direzione è descritto da Conforto nel settimo capitolo.
Naturalmente quello che abbiamo detto fin qui deve essere completato da una riflessione, che sarà svolta ampiamente in diversi capitoli (e qui solo accennata), sulle particolari caratteristiche psico(pato)logiche degli ospiti della comunità terapeutica: con le difficoltà di chi vive dentro la condizione psicotica a rapportarsi al simbolico, a tollerare separazioni ed eccessive intimità, vale a dire il suo necessario ancorarsi al concreto. L’operatore di comunità deve dunque perlopiù allontanarsi dalla dimensione psicoterapeutica simbolico-verbale, per affidarsi a quella a essa imparentata, ma più legata a oggetti concreti e a dimensioni non verbali, che informa di sé le attività riabilitative.
Quanto a queste, ci sembrerebbe non appropriato distinguerle in terapeutiche e di mero intrattenimento, poiché non avrebbe senso svolgere attività prive di un’intenzione curativa in un contesto che vuoi essere globalmente terapeutico; fra l’altro, se così le considerassimo, rischieremmo di sentirci esentati dall’indispensabile riflessione sul senso di tali attività. Piuttosto, può essere utile distinguere fra attività che – come lo psicodramma, l’arteterapia o la musicoterapia – intendono promuovere la dimensione dell’insight, e attività la cui impronta ludica tende a rafforzare, a volte necessariamente e a volte impropriamente, le difese della negazione: i giochi sportivi, i balli, le feste. Un’ulteriore dimensione è poi quella schiettamente prelavorativa, propria delle attività direttamente propedeutiche a un lavoro vero e proprio.
Comune a tutte le attività è infine l’intento risocializzante, il riproporre al paziente l’impegno dello stare comunque in un gruppo tenuto insieme da una finalità comune: in uno di quei gruppi, cioè, nei quali si articola la vita comunitaria. Certamente non sono stati gli psichiatri a inventare la comunità: si tratta di un aggregato antropologico antico quanto l’umanità stessa.
Le ideologie fondanti le comunità cambiano nel tempo; ma questi aggregati sociali “a tempo pieno”, di dimensioni limitate ma comunque superiori a quelle della famiglia nucleare, che si ripropongono continuamente nella storia umana, rispondono evidentemente a bisogni metastorici e metaideologici. L’analisi di questi bisogni è condotta da Conforto, Correale, Giusto, Salsa, nei loro capitoli, in riferimento sia alla comunità terapeutica sia al più vasto concetto antropologico di comunità. In particolare, le riflessioni sull’abitare conducono a considerarlo una funzione necessaria al consolidamento di quello che Correale chiama il “fondo del Sé”. A tale consolidamento e a una ripresa dell’evolutività del vivere sono necessari da un lato la costruzione di una quotidianità fluida e continuativa, dall’altro la capacità della comunità di dar vita a piccole soluzioni di continuità, eventi significativi o piccoli traumi. Se la realizzazione di ciò nella vita comunitaria può diventare una necessità stringente per lo psicotico, che – sottolinea Correale – cerca di evitare il ripetersi del terrificante trauma della crisi acuta, è un’esigenza anche della persona sana, che non a caso si accentua – la storia lo dimostra – nelle fasi di crisi sociale e politica.
Ma quanto è teoricamente legittimo integrare i due ambiti, quello clinico-terapeutico e quello più generale, antropologico?
La domanda introduce il problema della condivisione di una Weltanschauung (o visione del mondo), di un insieme di finalità fondamentali e di una dimensione emozionale, che definiscono la vera comunità, insieme alla condivisione di spazi e tempi: senza i primi, la comunità è artificialmente imposta, diventa istituzione; senza la seconda può diventare un legame debole e persino astratto, come potrebbe ad esempio mostrare la storia della Chiesa. Questa era dapprima un’assemblea (ecclesia) in cui la condivisione di spazi e tempi, pur non permanente, era tuttavia molto pregnante; poi è divenuta una vasta organizzazione ancora dotata di potente forza propulsiva; oggi per molti l’appartenenza a essa può essere una formalità. Nella comunità terapeutica, il problema della condivisione di una Weltanschauung – e più in generale di una comune realtà umana – senza che ciò conduca alla confusione o alla negazione del ruolo terapeutico, costituisce da sempre uno dei nodi fondamentali della riflessione sull’intervento comunitario: essa è infatti continuamente in crisi, da riproporre e realizzare ex novo ogni giorno, per la coesistenza nella comunità di due distinti gruppi, gli operatori e i pazienti.
La difficoltà si evidenzia maggiormente se si considera che i pazienti hanno spesso visioni del mondo fortemente individuali, narcisistiche e non condivise, mentre gli operatori sono portatori di un messaggio di rinnovamento non esente da una intenzione pedagogica: come ricorda Massa (1998), il sapere pedagogico ha sempre usato la residenzialità per produrre degli effetti.
Ma l’impronta rieducativa data alla riabilitazione può essere una trappola: la comunità terapeutica, se non vuole diventare la caricatura delle vecchie istituzioni, deve diventare lo spazio di produzione di nuovi significati. Tuttavia, l’intento pedagogico ha necessariamente un suo spazio, ricollegando la prassi comunitaria a classiche figure della psichiatria ottocentesca come Carlo Livi, che giungeva a equiparare la cura a una rieducazione. Inoltre, l’intenzione palingenetica a esso collegata ci riconduce ai grandi utopisti che, da Plafone a Tommaso Moro a Fourier, ravvisavano il luogo ideale dell’utopica rigenerazione dell’umanità in un mondo circoscritto e di piccole dimensioni, idoneo quindi a essere piegato a un progetto. Questo riconoscimento di una radice utopico-illusionale del progetto comunitario non deve tuttavia comportare una sua svalutazione, poiché, come ci ricorda Anzieu, il gruppo funziona naturalmente nel registro dell’illusione; e ciò a sua volta ci rimanda a Winnicott e alle sue riflessioni sull’illusione come momento fondante dello sviluppo psicologico infantile. Può questo essere riprodotto in quel new beginning che l’esperienza comunitaria si propone di essere?
Un altro nodo importante nasce dal sottolineare la naturalità della comunità terapeutica, considerata un caso particolare di comunità umana. Certamente lo svilupparsi dell’ideologia e della prassi comunitarie in contrapposizione almeno parziale a quelle ospedaliere è stato ispirato dall’esigenza di recuperare e rispettare quei bisogni umani metastorici di cui parlavamo pocanzi; dunque dall’esigenza di costituire un aggregato rispettoso delle esigenze “naturali” anche se, pur sempre, un prodotto culturale. Possiamo considerare riuscito il tentativo?
Il dubbio potrebbe nascere dal fatto che la comunità terapeutica ha sempre alle spalle un progetto teorico che la sostiene e l’ha fatta nascere, mentre lo stesso non vale per le comunità che nella storia si sono spontaneamente costituite, a partire dal loro prototipo, il villaggio. Questo non ha un’esplicita teoria fondante, e analogamente il castello nasce prima dell’ideologia feudale; d’altra parte, numerosi sono gli esempi di strutture comunitarie nate da una progettualità sostenuta dall’ideologia, come l’ideologia cristiana ha sostenuto il nascere del convento. Gli psichiatri, peraltro, hanno familiarità con il paradosso in base al quale fornire al rapporto di cura una cornice nettamente artificiosa e innaturale – vedi il setting psicoanalitico – è il presupposto per lasciar emergere modalità relazionali autentiche e “naturali”. E anche vero, come fanno notare Salsa, Berruti e Contini, che la comunità terapeutica sembra nascere come tentativo di recupero, nell’ambito delle organizzazioni sociosanitarie, di una dimensione di naturalità, e da un confluire parziale delle due impostazioni. Fra i connotati che Foulkes indicò come fortemente caratterizzanti l’esperienza di Northfield, appare fondamentale – sottolinea Peloso nel suo capitolo – lo spostamento dell’attenzione dal singolo al gruppo, dal dire al fare, dal passato al presente. Sono movimenti che sembrano voler introdurre nella prassi psichiatrica, modificandola profondamente, elementi caratterizzanti la vita nella piccola comunità naturale con la sua naturale terapeuticità.
Finiscono col confluire in questa direzione le osservazioni di Roteili – anch’egli citato da Peloso – che pure si inseriscono in una diversa ottica, fortemente critica: la comunità terapeutica, sostiene Roteili, non può non essere un artefatto che non ha nulla a che vedere con la vita normale della gente, anche perché “il discorso si sposta (…) alla ricchezza delle relazioni più che a un mito di partecipazione, quella pensabile soltanto in un luogo chiuso, un luogo in cui il tempo e lo spazio sono dominati da qualcuno che è in grado di stabilire i tempi e gli spazi in cui ciascuno sta. Viviamo invece in un mondo in cui il tempo e lo spazio devono essere possesso di tutti, in cui la gente è migrante, si sposta, va dove vuole, partecipa di quel che vuole, e non partecipa in modo globale e forte possibilmente di nulla”. Roteili si riferisce dunque al mondo sociale postmoderno, con le sue caratteristiche di globalizzazione, di mobilità, di precarietà. I suoi rilievi non contrastano, ci sembra, con la visione della scelta comunitaria come tentativo di recupero di stabilità e di definizione di un ambito e di confini sia pure elastici, risposta che non possiamo considerare regressiva o inadeguata al mondo in cui viviamo: essa ci pare invece utile in una serie di condizioni di forte disagio individuale e collettivo; infatti chiedere, a chi non è in condizioni di riuscirvi, di cimentarsi con situazioni di vita senza punti di riferimento definiti e stabili può significare chiedergli l’impossibile, e pertanto indurlo a risposte veramente regressive quale può essere l’isolamento autistico.
Qual è dunque il rapporto dell’aggregato comunitario con la più ampia collettività umana nella quale si è costituito e opera? Con la società nel senso di Tónnies cui si riferiscono Pisseri, Salsa e Gardella? E un rapporto sinergico e collaborativo, o necessariamente antagonistico? Anche su questo punto, il riferimento alla dimensione antropologica aiuta a riflettere sulla collocazione e sulla funzione sociale della comunità terapeutica.
La risposta è necessariamente articolata e sfumata. Ad esempio, non si può parlare di antagonismo nel caso della comunità tribale, che addirittura, se isolata dalle altre, si identifica con la collettività umana. Il castello, il kibbutz, il kolkhoz sono solo alcuni fra i possibili esempi di comunità che, lungi dall’essere in antagonismo con la collettività generale, ne hanno costituito una cellula fondamentale ed esemplare. In comunità come il convento il rapporto con la società ci appare forse più ambiguo: almeno oggi esso, in maniera più schiettamente paradossale, si propone come modello di vita a forte connotazione etica, ma proprio perciò si contrappone almeno in parte ai valori di fatto dominanti nella collettività generale. D’altronde, forse ciò è evidente oggi perché il convento è un’istituzione antica, e nel corso dell’evoluzione storica che investe ogni piccola comunità il sinergismo tende a perdersi. La piccola comunità, infatti, se sopravvive senza ridursi a un guscio fossile, vuoto e decorativo come il castello, tende comunque a cristallizzarsi, a non cambiare, a perdere il passo con i tempi.
Esistono poi altre tipologie di comunità, che germinano soprattutto nell’ambito dei centri urbani, come certi collettivi giovanili alternativi: per queste si può parlare di vero e proprio antagonismo, non esente da un’intenzione palingenetica nei confronti della collettività intera, o quanto meno dall’intenzione di proporsi come modello trasgressivo ma a suo modo, ancora una volta, esemplare. Nella comunità terapeutica persiste l’ambiguità. Essa fornisce un modello di vita e di rapporto che si discosta sensibilmente da quello della più ampia collettività nella quale si colloca; ma la distanza non può essere eccessiva, poiché la finalità deve essere sempre quella del reinserimento.
Ancora Peloso osserva che, quanto più la comunità terapeutica tende a distinguersi, a isolarsi in una splendida autarchia rispetto alla comunità generale, alla città, quanto più cioè sembra esprimere totale alterità e antagonismo, tanto più si fa anche subalterna rispetto a esigenze di esclusione e finisce col trasformarsi in una sorta di cisterna – fosse anche dorata – di esistenze per mille motivi reiette e spinte fuori.
Riteniamo che la comunità possa, mantenendo un sensato equilibrio e curando la propria permeabilità verso il mondo esterno, sot-trarsi a questa degenerazione: ma difficilmente potrà evitare di costituire una cellula della collettività generale, specializzata nel trattamento, almeno temporaneo, di situazioni difficilmente integrabili nella collettività stessa. Quest’ultima può riconoscere, come sta oggi avvenendo, un’utile risorsa nella “diversità” della proposta comunitaria, che perciò può e deve differenziarsene, ma non essere antagonistica.
Ancora qualche parola introduttiva. Normalità: condizione riferibile alla consuetudine o alla generalità, interpretata come regolarità o anche ordine (Devoto-Oli); se partiamo da questa definizione per intendere il compito, il desiderio, l’ambizione, lo scopo che ci induce a prenderci cura dei pazienti psichiatrici gravi, possiamo forse capire che questo concetto deve essere inteso sia in merito allo spazio che al tempo che alle modalità di relazione, e quindi alla capacità di stare insieme, di muoversi, comunicare, manifestare affetti ecc. La comunità è il luogo dove tutto ciò si verifica, e la famiglia è la sua prima naturale espressione. Proporci quindi di istituire delle comunità che definiamo tera-peutiche per pazienti psichiatrici, deve necessariamente tenere conto del dato storico e antropologico-culturale. Lo scopo del nostro lavoro e il contributo che vogliamo fornire a chi decide di consultarci, leggendoci, è una riflessione da vertici di osservazione diversi, su esperienze dirette o mediate che hanno a che vedere con la cura del paziente psichiatrico, la comunità terapeutica, la comunità allargata.
Tema quanto mai attuale in un momento come questo in cui si celebra il ventennale della famosa legge 180 e si stabilisce la definitiva chiusura degli Ospedali Psichiatrici. In un lavoro del 1991 Giusto ha detto che la follia è da ritenersi (tra le altre cose) un tentativo disperato e inevitabile di ribellione nei confronti di un modo schematico e statico di intendere il concetto di normalità; gli ospedali psichiatrici e i metodi di cura che rispondevano a una logica positivistica rappresentavano una risposta simmetrica che tentava di ricondurre in maniera forte alla normalità: tentativo destinato inevitabilmente a fallire.
Il fallimento era generato anche dalle dimensioni eccessive di queste strutture e dalla scarsa possibilità di creare al loro interno un clima familiare caratterizzato da comprensione, calore umano, reciprocità, attenzione ai bisogni degli altri, ascolto.
La naturalità di tali situazioni, che si rifanno alla comunità originale, cozza contro la necessità di organizzare luoghi di cura che siano regolamentati da concezioni che si rifanno strettamente al modello medico; le strutture che vengono definite intermedie tra l’ospedale e la civile abitazione devono rispondere, sia dal punto di vista architettonico che da quello dell’organizzazione interna, a esigenze relative al compito di ricondurre l’ospite verso la dimensione di normalità.
Le comunità terapeutiche in Italia nascono subito prima della legge 180 e si sviluppano in modo irregolare nel territorio, spesso come momenti separati del processo di cura; ne è derivata la necessità di un coordinamento e di un punto di incontro, per cui è stata creata la FENASCOP (Federazione Italiana Strutture Comunitarie Psicosocioterapiche), che raccoglie comunità private e del privato sociale e che ha lo scopo di divulgare la cultura della comunità terapeutica. I problemi di realtà si inseriscono prepotentemente nel campo strettamente operativo e con esso interagiscono; la psichiatria, più di altre branche della medicina, risente del clima politico e con esso deve fare i conti; è necessario ottenere il consenso su un determinato modello organizzativo, e a tale scopo bisogna acquisire credibilità potendo esibire risultati, che peraltro sono anch’essi influenzati nella loro lettura da ideologie o schieramenti di scuola. Il percorso è quindi faticoso, a volte tortuoso, lento: la comunità (politica) influenza in modo importante la comunità terapeutica, i limiti tra le due sfumano, e c’è il rischio che la seconda perda specificità, definisca così il suo ruolo in campo più assistenziale inducendo, anziché potenziale evoluzione, cronicità o regressione.
Qual è quindi il ruolo dei tecnici in questo ambito? Deve evidentemente essere un ruolo di collegamento tra diverse competenze e culture, di cerniera tra il privato e il pubblico, di forte presa di coscienza della necessità di esprimere modelli organizzativi in ambito lavorativo che evitino i fraintendimenti che prima paventavamo e sottraggano ad altri quelle competenze che arbitraria- mente vogliono esprimere: ad esempio, gli architetti e gli ingegneri devono essere al servizio di un’idea di struttura comunitaria espressa dagli psichiatri e dagli operatori, piuttosto che viceversa, come spesso accade.
C’è quindi un problema di visibilità pubblica di quello che la comunità terapeutica è in grado di esprimere come strumento di lavoro, e c’è un problema di comunicazione tra gli esperti nell’ambito dei vari settori di competenza, che non possono essere tra loro scollegati. Un’idea moderna di organizzazione del lavoro deve prevedere la flessibilità dei ruoli, che non significa rinunciare alla propria specificità, ma essere disponibili a un confronto a volte anche serrato; questa, tra le altre, è un’idea del “comune”, ovvero “pertinente a una comunità di persone socialmente organizzate” (Devoto-Oli).
